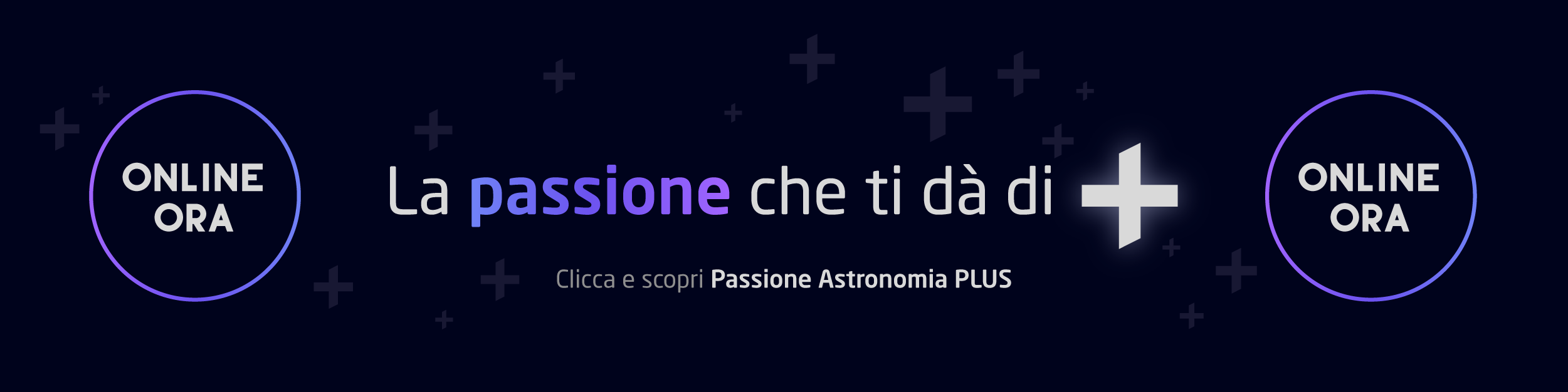Seconda puntata dedicata all’evento aurorale/SAR del 10/11 maggio 2024 (vista anche in Italia)
Seconda puntata dedicata all’osservazione dell’evento dell’aurora boreale/SAR del 10/11 maggio 2024. Ricordiamo che in questa serie di tre articoli (il primo lo trovi qui) non vogliamo soffermarci su cosa ha prodotto il fenomeno ma su cosa si è visto con gli occhi e con le fotocamere, per fare chiarezza di pareri, commenti e domande su foto e testimonianze oculari.
Le tre puntate, per non rendere lunghissimo e impossibile da leggere l’intero articolo, cercano di rispondere a queste domande:
- Cosa si è visto a occhio nudo?
- Cosa si vedeva in fotografia? (smartphone e fotocamere)
- Come si vede l’aurora a occhio nudo in Lapponia paragonata all’evento del 10/11 maggio in Italia?
Proseguiamo affrontando la seconda domanda.
Cosa si vedeva in fotografia?

Se l’occhio umano è progettato per vedere bene di giorno e in condizioni di luce solare intensa, la fotocamera digitale (sia questa una macchina fotografica vera e propria o quella di uno smartphone) dà il meglio di sé nelle stesse condizioni di luce ma se la cava molto bene anche in condizioni di scarsa illuminazione (e quindi anche di notte o in condizioni di luce scarsa). Il sensore CMOS, cioè l’elemento sensibile alla luce delle fotocamere/smartphone, è per sua natura più sensibile alla luce di quanto non lo sia l’occhio umano, ovvero serve una minor quantità di luce per poter registrare un segnale e questo permette di rappresentare agevolmente sul display (e di salvarle nel file RAW o jpg) luci tenui con il loro colore, che al nostro occhio apparirebbero monocromatiche.
Il caso dell’aurora/SAR la notte dell’11 maggio è un ottimo caso di studio
Nel precedente articolo abbiamo fatto un confronto di come l’aurora appariva a occhio nudo e di come appariva nella foto finale; qui introduciamo un elemento in più, ovvero come appare l’aurora/SAR nell’immagine acquisita e processata dalla fotocamera senza alcun passaggio in post-produzione (ovvero senza alcun tipo di elaborazione digitale). Al primo sguardo la fotocamera/smartphone ha una visione molto più profonda, dettagliata e colorata del nostro occhio in queste condizioni di bassa luminosità e basso contrasto: ciò che l’occhio vedeva in bianco e nero e con molti limiti nei dettagli la fotocamera lo rende ben visibile. Potete quindi immaginare l’emozione provata quando alternavo la visione dello spettacolo attraverso i miei occhi e la potenza dei colori che vedevo sul display della mia fotocamera!
Da questo punto di vista la fotocamera parte avvantaggiata: al sensore serve poca luce per “vedere” bene determinati colori; pensiamo ad alcuni colori che il nostro occhio vede a malapena: l’emissione H-Alpha a 656 nm, che è un rosso molto molto scuro per il nostro occhio quasi per nulla percettibile il sensore CMOS lo “vede” decisamente molto meglio! Le tonalità rosse dell’aurora e il SAR (che è rosso anch’esso) emettono luce a 630 nm (che è un rosso più brillante dell’H-Alpha) e qui il nostro occhio si comporta decisamente meglio: la fotocamera “vede” benissimo questa la luce a questa lunghezza d’onda ma anche l’occhio non se la cava malaccio. E allora perché l’aurora/SAR appariva grigia e/o vagamente rossa? Che cosa fa la differenza qui? L’intensità della luce.
La debole luce aurorale/SAR solo a tratti riesce a essere così intensa da stimolare le cellule della retina che ci fanno percepire il colore rosso (ecco perché a volte l’abbiamo vista rossa con i nostri occhi!) mentre la fotocamera, l’abbiamo già detto, in condizioni di basse luci riesce a catturare l’informazione più efficacemente. Ci sarebbe, inoltre, da distinguere bene il comportamento dell’occhio durante la visione diurna (fotopica) e notturna (scotopica) ma qui ci limiteremo solo a sottolineare che la visione notturna agisce negativamente sulla percezione del colore rosso e, di conseguenza, rende più difficile osservare la parte rossa dell’aurora e il SAR.

Riassumendo, la fotocamera (o meglio il sensore CMOS), ha il vantaggio che “vede” meglio in condizioni di luci deboli e “vede” meglio anche alcuni colori a cui l’occhio è poco o per nulla sensibile e questo è il motivo per cui la fotocamera restituisce già un’immagine super-entusiasmante sul display! A questo punto, registrata e processata l’informazione che il sensore CMOS “vede” e salvata nel file RAW, una volta giunti a casa entra in gioco la post-produzione, ovvero quella serie di procedure di sviluppo digitale dell’immagine per estrarre tutta l’informazione contenuta nei dati. Non c’è nulla di magico né è questione di trucchi o inganni, è solo la potenza della matematica dietro ai software di elaborazione (Photoshop, PixInsight, Siril, ecc…). Certo, parliamo di elaborazione, non di arte (tipo pennellare l’immagine e introdurre dati che non esistono) o di generazione immagini con l’intelligenza artificiale.
I dati dei pixel nell’immagine li possiamo immaginare come bicchieri più o meno vuoti di acqua: se non c’è acqua nel bicchiere il colore del pixel è nero (nessuna informazione) mentre più acqua il bicchiere contiene e più il pixel è luminoso; se l’acqua trabocca dal bicchiere allora il pixel è saturo ovvero completamente bianco. Con questo esempio si comprende come sia molto facile notare la differenza fra un bicchiere (un pixel) pieno a metà e uno pieno a ¾ a occhio nudo ma ben differente è notare la differenza fra due bicchieri (pixel) dove uno dei due ha una singola goccia d’acqua in più: a occhio non è possibile distinguerli ma uno dei due effettivamente contiene più acqua dell’altro! Un pixel ha registrato più informazione dell’altro, pochissima, ma c’è anche se non ce n rendiamo visivamente conto! Ed è qui che interviene l’elaborazione di post-produzione: serve appunto per evidenziare meglio queste lievissime differenze che l’occhio non vede (ma che esistono nei dati!) e che si traducono nell’immagine finale in dettagli fini più visibili, colori più vivi, contrasti migliorati.
I colori dell’aurora boreale / SAR
Ecco spiegato come mai le foto di quest’evento aurorale/SAR sono tutte molto colorate, ben definite e nitide e così diverse dalla visione a occhio nudo: potenza del sensore digitale, più bravo di noi a “vedere” il rosso durante la notte, affidato a mani che hanno saputo elaborare correttamente l’immagine per estrarre tutta l’informazione in essa contenuta. Va da sé che la foto, quindi, non riporta esattamente ciò che l’occhio vede nel cielo e che la mano che elabora l’immagine deve essere il più “neutrale” e delicata possibile, mantenendo una coerenza reale con il fenomeno… perché altrimenti potremmo ottenere foto con colori completamente non corrispondenti a quelli naturali del fenomeno.

Giunti qui si potrebbe pensare che la fotocamera non riproduca realmente il fenomeno solo perché a occhio nudo questo appare differente: ricordiamoci sempre che solo perché alcune informazioni come luce, colori e dettagli non si vedono bene o non si vedano affatto a occhio nudo non significa che non esistano nella realtà e, in questo senso, l’avvento dei sensori digitali ha aperto le porte a una fotografia più flessibile e con enormi possibilità/potenzialità. Foto e visione a occhio nudo dell’evento di aurora boreale / SAR del 10-11 maggio 2024 sono profondamente diversi ma regalano entrambi emozioni sorprendenti. Ma come si vede a occhio nudo un’aurora boreale in quei territori dove questi fenomeni si manifestano sopra la nostra testa e nella loro completa potenza? Lo vediamo nel prossimo articolo.